- IL COACH SIM-PATICO
3.1 Il caso: il coach ungherese.
Quello sì che è stato un giorno importante per il coach. Sembrava proprio un giorno come gli altri, invece ha cambiato la sua vita. Eppure era iniziato come sempre. Quella mattina il coach girava per casa senza meta, la sera aveva bevuto quasi un bottiglia di Nardini, gli era rimasto un bel mal di stomaco e la notte non aveva dormito. Il coach non dorme mai prima delle partite. Una volta dormiva tranquillo, ma non dorme più prima delle partite da quel giorno della finale. La partita era nel pomeriggio. Non sarebbe riuscito a rimanere a casa. Il cane, Laika, un vecchio peloso pastore tedesco, maschio, nonostante il nome dovuto alla stravaganza del coach, perdeva peli. Al coach ungherese non andava proprio di passare una mattina a spazzolarlo. Prese il treno per Roma. In città il sole picchiava forte, il coach sudava, si è trovato per caso davanti alla libreria Feltrinelli ed è entrato, più che altro per l’aria condizionata. Si è fermato due ore ma non ha comprato nulla. Sapeva prima di entrare che non avrebbe comprato nulla. Non c’era nessuna novità interessante, quel poco di buono che è stato scritto l’aveva già letto. Una nuova edizione di Cattedrale di Carver era l’unica tentazione esposta. L’americano è uno che racconta la vita, senza veli, così com’è. I suoi personaggi non hanno spessore, non hanno storia, non hanno futuro. Senza spessore e senza futuro, così si sentiva il coach, quel giorno. Non aveva un futuro da quel giorno della finale, da quella notte passata con lei, insonne, a bere, piangere, ascoltare e parlare. Dal giorno della finale, prima di ogni partita, ha provato a leggere una storia di Carver, ma il nervosismo alla fine la spunta e il coach non finisce mai il racconto che inizia a leggere e del quale già conosce ogni parola. Però ci prova lo stesso ad iniziare un racconto. L’ultimo regalo che le fece fu una bella edizione di Cattedrale, le piacque. Da quel giorno per il coach Carver è sacro. Mentre si trascinava tra gli scaffali della libreria, un tizio con i jeans strappati, un orecchino con il ciondolo ed i capelli tagliati ad isolotto si è avvicinato proprio allo scaffale che conteneva le opere di Carver. Parlava con un suo amico, il linguaggio era volgare e sgrammaticato. Il ragazzo fu attratto dalla bella copertina di Cattedrale, lesse il nome dell’autore e chiese al compagno: “….e questo chi cazzo è?”. L’altro mugugnò : “damoje ‘na letta”, poi, il ragazzo con i jeans strappati, un orecchino con il ciondolo ed i capelli tagliati ad isolotto ha preso il volume, l’ha messo in tasca piegandolo in due e si è avvicinato alla cassa. Il coach gli è piombato davanti e gli ha mollato uno schiaffo, “questo, tu…. lo lasci stare!” Due energumeni di colore lo hanno preso e buttato fuori, al caldo. Per un ungherese che vive in Italia essere buttato fuori da un locale non è una novità. Il coach è stato un allenatore importante, ma questo l’addetto alla sicurezza di Feltrinelli non poteva saperlo, per lui era un ungherese ubriaco che prendeva a schiaffi i clienti.
Il coach allora ha camminato un po’ per Roma. L’insegna di un negozio gli ha ricordato il suo cognome, il cognome del suo pupillo, quello che ha lasciato la sua alzatrice di sempre, la sera prima della finale. A quel punto il coach è entrato all’Habana, un locale a trecento metri dalla sua gelateria preferita, ha preso una Nardini ghiacciata. Erano le undici di mattina, un pugno allo stomaco avrebbe fatto meno male, il barista, un tizio anziano ed esperto, uno di quelli che non te la manda a dire, lo ha guardato e riguardato, poi, con la Nardini già nel bicchiere, ha preteso che prima lo pagasse. Il coach ha chiesto il permesso di portare il bicchiere in strada, giusto all’angolo del locale, ci ha fumato sopra un cubano, tanto per tappare il buco dell’ulcera e ha passato un quarto d’ora spazzando la mente da ogni pensiero. Ha girato l’angolo e si è seduto dentro un altro pub, la Miscellanea. Ha ordinato un panino ripieno di tacchino e l’ha mangiato in mezz’ora, bevendoci sopra un litro di Moretti scura alla spina. Si sentiva stanchissimo. Ora però aveva la testa libera dai demoni e finalmente poteva pensare al suo problema. Quel problema era un piccolo problema per un coach che aveva giocato la Finale, però continuaiva a girargli fastidioso per la testa, come una mosca che ti entra nella macchina in autostrada. Adele, la giovane alzatrice, era ferma sui piedi, aveva le gambe pesanti, non c’era con la testa. Certo, Adele era molto brava, il punto di forza della squadra, però in quel periodo stava preparando l’esame di maturità, era in crisi con il ragazzo e proprio non riusciva a pensare ai play off. Erano un paio di mesi non alzava un pallone giocabile, le compagne lo sapevano e non facevano altro che aggredirla. Lei le ripagava alzando loro palloni sempre più sporchi.
Non c’era soluzione e il demone si rifece sotto con i ricordi che di nuovo prendevano il sopravvento. Questa volta toccava alla famosa semifinale, il suo capolavoro, l’opera d’arte della sua alzatrice. Rivide, come in una pellicola consumata dalle troppe visioni, quell’ultimo punto. Parte la battuta flottante delle russe, è più corta del solito e costringe la centrale ad occuparsi della ricezione, la palla esce male dal bagher goffo di una ragazza alta due metri e zero due. Lei, la sua alzatrice, è già lì al suo posto, ma deve spostarsi nuovamente per trovarsi sotto la palla al momento giusto, si raccoglie tutta e poi esplode il suo corpo verso l’alto, si inarca per il palleggio dietro, sembra una ranocchietta con i capelli neri come la pece, tocca la palla che parte morbida e veloce dietro, verso la migliore attaccante che è partita ancora una volta per la rincorsa e che arriva sulla palla al momento giusto. Il muro avversario però è già piazzato, l’opposto tocca potente ma non gira il polso per evitare il muro, la palla impatta le mani delle avversarie e ritorna veloce, quasi imprendibile, quasi già a terra. Quasi. Lei, la sua alzatrice, si tuffa carica di adrenalina e posa la mano sul parquet, un attimo prima che il pallone lo tocchi. La palla prende una traiettoria insidiosa e schizza verso l’opposto che si muove lenta e non riesce a piazzarsi per il bagher, si difende con il gomito e spara il pallone ancora verso di lei, la sua alzatrice: i tendini si attivano come corde d’acciaio, la schizzano in piedi, ed allora, ancora in equilibrio precario, si accorge che la palla la sta quasi superando. Quasi. Si coordina con quel suo stile tutto particolare, a volte quasi grottesco. Il coach coglie nei suoi occhi accesi la speranza: l’alzatrice ha il tempo di guardare le avversarie festeggiare il punto del pareggio, questo deve averle dato la forza per saltare ancora in cielo ed indirizzare un attacco lento ma preciso verso l’incrocio della linea di fondo con quella laterale, in zona cinque, dove il coach le dice di tirare in queste situazioni da quando aveva quindici anni. Le russe restano di pietra, la palla cade a terra, non resta loro che il tempo di guardare l’arbitro. Il mondo è ai piedi della sua alzatrice.
Davanti alla Moretti scura alla spina il coach ungherese pare rapito dai suoi sogni ricorrenti e non ha la forza di pensare al problema di oggi, quello della sua giovane alzatrice.
L’unico motivo per cui era rimasto a Roma in attesa del treno delle 17, 20 dalla stazione Termini era comunque un altro: il solito affogato allo zabaione da Fiocco di neve, la migliore gelateria di Roma, almeno per quanto riguarda lo zabaione. Prese prima un cono da due euro, solo zabaione e panna. Si fece tre giri del Pantheon e già le idee sembravano schiarirsi. Rientrò nel negozio e senza meraviglia da parte della commessa ordinò l’affogato allo zabaione. Un momento che da tanti anni per il coach vale un’esistenza: si lascia svuotare la mente, concentra lo spirito sulla punta della lingua e solo quando perde il senso della realtà lascia che il senso della vita gli entri di nuovo dentro, attraverso il forte sapore dello zabaione affogato. Il rito si conclude nell’ebbrezza appena suggerita dall’ alcool.
A quel punto poteva sopportare di giocare, un’altra finale. Ancora una finale, dopo la finale, quella perduta, con lei che piangeva in campo, le compagne che lo guardavano attonite, le televisioni che lo inquadravano praticamente ubriaco e privo di ogni interesse per la partita. Un’altra finale dopo che quel maledetto ragazzo aveva distrutto la sua vita, la vita della ragazza che aveva allenato per dieci anni, con la quale aveva diviso ogni gioia ed ogni dolore. Che ne sanno di questo quelli che hanno scritto del fallimento del coach ungherese dopo quella finale? Che ne sanno di quella notte passata ad ascoltarla mentre piangeva e a guardarla mentre gli raccontava il suo dolore?
Da quel giorno è arrivata la fine della sua carriera, l’inizio della sua storia di alcolista, tante partite giocate, sempre in una serie inferiore, sempre più in basso, quasi sempre perdute. Anche quel giorno, quello dei buttafuori di Feltrinelli, della Nardini, della Moretti e del gelato allo zabaione, sembrava quasi tutto senza interesse. Quasi. Quel giorno, il giorno che lo ha rimesso al mondo, dopo la mattinata passata a Roma, entrò in palestra ancora una volta in condizioni pietose. Senza coglierne il motivo strappò la foto della nazionale che ancora era appesa sopra la testa della segretaria del centro sportivo. Il Presidente, un ometto piccolo e panciuto, ebbe un bel da fare per portarlo nello spogliatoio, mettergli la testa sotto la doccia e riportarlo in campo in condizioni apparentemente normali.
I genitori delle ragazze non ne potevano più e dopo la partita lo avrebbero licenziato. Nello sport si chiama “esonero”, ma è peggio, molto peggio di un licenziamento.
Il set si mise subito male, le avversarie passavano facilmente, Adele non ne imbroccava una e il coach non aveva perso il vizio: l’alzatrice non andava toccata. Le compagne non la risparmiavano, chi voleva l’alzata più veloce, chi un pallone più alto, chi più staccato da rete. La poveretta aveva le lacrime agli occhi, guardava fuori dal campo, verso il suo ragazzo, ma non riusciva a reagire. Aveva smesso di guardare il coach negli occhi: sapeva che il suo allenatore non tollerava essere guardato dalle giocatrici in lacrime. Non lo tollerava più dalla finale.
Fu allora che il coach ascoltò una voce alle sue spalle, dalla tribunetta riservata agli addetti ai lavori: -coach, parlale del naso di Michelangelo!
Non ebbe bisogno e forse il coraggio di voltarsi. Chiamà un time out, era noto per non chiamarne mai, dal giorno della finale. Prese Adele da parte e le raccontò la storia: “Michelangelo aveva appe na finito il suo Davide, uno dei committenti entrò nel laboratorio e obiettò che il naso era troppo pronunciato. Il maestro, allora, raccolse la polvere di marmo, simulò qualche scalpellata sul naso, fece cadere della polvere, si voltò verso il nobile e chiese se ora il naso potesse andar bene. Quello annuì soddisfatto”. Così avrebbe dovuto fare la giovane alzatrice con le sue compagne. Dare loro la palla che chiedevano, ma sempre la stessa, quella che aveva deciso lei, insieme al coach.
na finito il suo Davide, uno dei committenti entrò nel laboratorio e obiettò che il naso era troppo pronunciato. Il maestro, allora, raccolse la polvere di marmo, simulò qualche scalpellata sul naso, fece cadere della polvere, si voltò verso il nobile e chiese se ora il naso potesse andar bene. Quello annuì soddisfatto”. Così avrebbe dovuto fare la giovane alzatrice con le sue compagne. Dare loro la palla che chiedevano, ma sempre la stessa, quella che aveva deciso lei, insieme al coach.
La partita andò come doveva andare, a distanza di tanti anni nessuno, tranne Adele e il coach, ricorda come finì. Tutti però ricordano che finita la partita il coach si voltò e la vide per un attimo. Lei lo salutò con la mano, gli indicò soddisfatta Adele, la sua giovane erede. Il coach colse nei suoi occhi neri la scintilla dei tempi che furono. Era ancora giovane, forse era anche bella, si sorprese a pensare il coach ungherese. Era accompagnata da un uomo, una faccia buona, serena, un bel ragazzo.
Da quel giorno il coach riprese ad allenare, ma soprattutto ricominciò a prendersi cura dei suoi ragazzi.
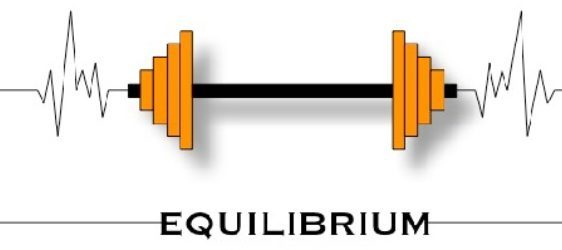

Un pensiero riguardo “Platone e la battuta float. Quarta parte. Un coach per amico.”