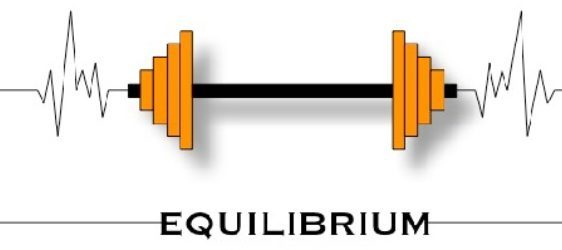perché io lo faccio?
Carletto Mazzone racconta, nella miniserie Netflix “Come un padre”, un episodio che lo riguarda. Ormai a fine carriera, avanti con gli anni, arriva in una nuova squadra e sbotta con i suoi giocatori: ragazzi, voi siete 26 e io uno. Prima che io entri nella testa di tutti è finito il campionato, facciamo prima se voi entrate nella mia.
Certo, parlava del suo modo di vedere il calcio, del suo stile di allenamento, della sua tattica. Chi ha avuto la fortuna di essere allenato da Mazzone racconta che però quell’allenatore non era solo questo.
Era proprio “Come un padre”.
Perché? Intendo: perché Mazzone era quell’allenatore lì ed altri erano diversi? Perché non si limitava ad insegnare come si tira in porta, come si fa il fuorigioco, come si tira un calcio d’angolo?
Il fatto è che nella testa e nell’intimo di un coach non entra mai nessuno.
Ci sono amici dei quali non è lecito dubitare e quindi bisogna prendere con la massima attenzione la loro provocazione. In un nostro scanzonato dibattito sull’inizio di una mia nuova avventura da allenatore, uno di loro mi scrive:
Secondo me come la maggior parte dei genitori usa i propri figli per affermare se stesso, la maggior parte degli allenatori usano i figli degli altri per affermare se stessi. Tutti in falsa coscienza e con gli apparenti buoni propositi …
Può darsi.
In questa affermazione c’è senza dubbio del vero. In ogni nostra attività c’è l’affermazione di se stessi. Lo ha insegnato Hegel. Marx, che lo ha sviluppato, sostiene che il furto del “se stesso” contenuto nel prodotto del lavoratore (alienazione) è uno dei peccati del capitalismo. In qualche modo quando si travisano le intenzioni di un coach, gli si ruba la sua oggettivazione. Il concetto non è semplicissimo da spiegare, ma è una brutta cosa.
Il giudizio su questo fatto dipende da chi si è. Di conseguenza cambia la percezione di quale sia il risultato dell’affermazione di se stessi. Anche un feroce dittatore afferma se stesso nelle proprie azioni e sarebbe meglio che non lo facesse. Ma neanche questo discrimine ti salva. In gioventù ho sentito muovere le stesse obiezioni a Madre Teresa di Calcutta. Lo fa perché vuole che gli altri la vedano come una santa.
Non c’è scampo.
Ma non è questo il punto.
Perché un coach, fa il coach? Le parole sono importanti. Non parlo di istruttori, allenatori che timbrano il cartellino, professori di educazione fisica che arrotondano il loro stipendio perché hanno famiglia e allenano la qualunque (anche qui con tutto il rispetto e con tutte le eccezioni). In molti casi le motivazioni sono materiali, economiche, dovute al rispetto del proprio ruolo nella società, al fatto che ti sei trovato a vivere allenando.
No, parlo di gente che magari ha già un lavoro, una famiglia e riempie la propria attività in palestra di “contenuti” che eccedono la prescrizione tecnica. In genere sono allenatori in sport di squadra che contemplano nel loro lavoro la gestione del gruppo, la crescita degli atleti, regole alle quali la squadra deve attenersi, scelte etiche apparentemente banali (chi è forte e salta allenamenti in settimana, poi la domenica gioca? Almeno nelle giovanili bisogna far giocare tutti? ) e temi di maggior rilievo: se la società sportiva è comunque un’agenzia educativa, come si rapporta alle altre: la famiglia in primis, la scuola, la parrocchia? Può o deve trasmettere valori? Quali sono questi valori in una società plurale?
Ci sono poi meta temi che riguardano l’allenamento: prescrittivo, con margini di adattabilità in relazione al gruppo e ai singoli, con richieste ai giocatori di scelte o vincolati… molti allenatori non sanno che seguono un modo di allenare fondato su principi cognitivi precisi, altri studiano e scelgono.
Perché una persona normale si mette in questo ginepraio? Quando devo rispondere a questa domanda mi sento nelle orecchie le stesse vocine che mi tormentavano quando ho avuto piccole esperienze politiche: se lo fai è perché hai il tuo tornaconto. Oppure, per l’appunto: così trovi il modo di affermare te stesso.
Può darsi.
La risposta che ho dato ai miei amici veri è che lo sport è l’ultima utopia che mi è rimasta e sono certo che in questo io non sia il solo.
L’idea che nello spazio angusto di una palestra si possa fondare una mini società radicata in alcuni valori fondamentali. Una squadra, non un gruppo di amici, dove ognuno sa che ne esce bene insieme agli altri, se ciascuno svolge il proprio compito e guarda con fiducia a quello degli altri. Una società in cui è favorita la crescita personale, ma contemplata in un contesto di squadra e funzionale alle esigenze della squadra. Un posto nel quale uno che attacca un pallone sa che ci sono compagni pronti a raccogliere una murata, così al tempo stesso ognuno corre in copertura per evitare all’attaccante una figuraccia e alla squadra di subire un punto. Il mio sport, poi, la pallavolo, ti insegna che vince solo la squadra, che sei obbligato a passare il pallone, che non puoi correre in tutte le zone del campo, ma hai la tua e sei chiamato a tenere in ordine il tuo giardino.
Non conosco altro modo di educare alla solidarietà, all’inclusione, al rispetto degli altri e del lavoro degli altri, alla responsabilità sul compito che ci è stato affidato. Non conosco altro modo per fare io stesso esercizio di questi valori e di migliorarmi.
Poi sì, voglio vincere. Penso sempre che i ragazzi della mia squadra siano i migliori e farei qualsiasi cosa per festeggiare la vittoria in un campionato, in una partita, in un set. Ma queste sono conseguenze.
Vorrei far sapere al mondo di essere il migliore allenatore, un po’ come Madre Teresa secondo i malevoli voleva far sapere di essere una santa?
Può darsi.
Retorica?
Può darsi.
Nessuno ci chiede questo?
Può darsi.
Sinceramente però penso che esiste lo sport del professionismo, quello delle Olimpiadi, ma se la gente è contenta di fare sport e può fare sport lo deve a tanti piccoli utopisti che ogni giorno affermano se stessi nell’ambito di un interesse collettivo e aiutano tanti a fare tante belle esperienze che si ritroveranno per tutta la vita. Tanti piccoli sarti di quartiere che si ispirano alle sfilate di moda e confezionano vestiti dignitosi per i propri clienti.
In un mio piccolo lavoro, Il Gioco di Sophia, ho tentato di spiegare meglio, ho cercato di indicare esempi, anche di persone famose che ce l’hanno fatta. Gente che per davvero era ed è tra i migliori. Coach Wooden, Phil Jackson, Julio Velasco e tanti altri ci dicono che il modello piscina (senza offesa) non funziona. Non entri, fai i tuoi cinquanta minuti e te ne vai. Soprattutto: la doccia, alla fine, non porta via tutto il cloro. Qualcosa resta sempre.