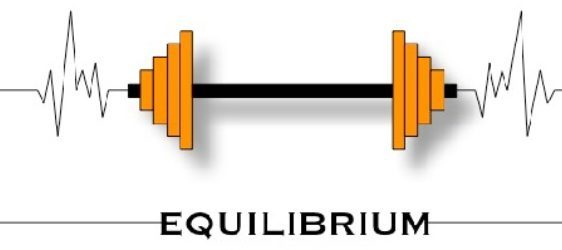Nella pratica filosofica applicata allo sport c’è una direzione di flusso piuttosto evidente: dalla filosofia alla pratica. Questa è l’accezione semantica che sottende all’espressione Consulenza filosofica. C’è un sapere e c’è la messa in pratica di questo sapere.
Quello meno evidente, ma forse ancora più potente, è il flusso contrario: dalla vita alla filosofia. Qui, invece, stiamo sul versante della pratica filosofica. C’è una pratica sapiente e ci sono dei ritorni per implementare, modificare, correggere il saputo. Nella pratica filosofica ci vedo tutto Socrate, nella Consulenza l’Accademia.
Nel primo caso c’è un boss (il pensiero filosofico) che in qualche modo detta le sue condizioni a chi poi dovrà mettere sul campo una più o meno illuminata consulenza filosofica. Avremmo qui consulenze di vita, consulenze sul lavoro, consulenze nello sport. Tutto molto bello e attuale. Tutto questo è fondato da quello che il Consulente sa e si fonda sulla tradizione filosofica. La Consulenza è una lodevole messa su strada di questo sapere.
Il pensiero comanda e qualcuno si sporca le mani.
Non funziona così, o almeno così non funziona.
Credo che sia utile riflettere sul fatto che attraverso l’osservazione e attraverso la stessa pratica filosofica possiamo mettere a punto le nostre convinzioni filosofiche, far cambiare idea al boss, il quale, essendo un filosofo, dovrebbe prenderla bene.
Almeno dovrebbe provare a trarne vantaggio.
Vediamo meglio e sul concreto. Prima di occuparci del caso promesso nel titolo, quello del talento sportivo, facciamo un passo indietro. Torniamo nella casa del boss, il pensiero filosofico. Un fiume fecondo quanto le esondazioni del Nilo, ha attribuito da duemilacinquecento anni ad oggi, una qualche preconoscenza innata o insita in ciascun uomo. Lo stesso potremmo dire di alcune abilità.
Si comincia dalla reminiscenza di Platone, si passa per la lettura cristiana di Agostino, si arriva agli archetipi di Jung e alle strutture innate del linguaggio in Chomsky.
Anche qui: tutto molto bello e affascinante. Nel derby tra i sostenitori dell’hardware (capitanati da Aristotele, Tommaso, gli empiristi e i positivisti) contro il software già installato e pieno di contenuti io tifo per la squadra di Platone.
È evidente: qualcosa che noi dimostriamo di sapere, o di saper fare non è giustificato in maniera esauriente dagli insegnamenti che abbiamo ricevuto.
Parlando di sport: Maradona, Totti, Baggio si sono allenati come gli altri. Forse anche meno. Perché allora loro sono talenti e altri sono condannati ad una vita da mediano?
In palestra o sui campi di calcio la squadra per cui tifo, quella che va da Platone a Chomsky , quando si fa consulenza, parla di talento, classe, potenzialità. Tutta roba che hai già dentro, per diventare quercia bisogna soltanto innaffiare la ghianda. Hilman gongola.
Quindi sembrerebbe che talento si nasca. Poi con un po’ di fortuna e le giuste cure quel seme che il talento ha in sé esce fuori.
Il De Magistro di Agostino è un libro chiave per rispondere alla domanda filosofica di un allenatore sportivo di terza categoria. Il coach, ti aiuta a tirar fuori quello che hai dentro. Adesso che abbiamo anche un papa agostiniano, Agostino è preso sul serio.
Il fatto è che tutti, ovviamente, pensano di avere tanto talento.
Per la legge della domanda e dell’offerta si sono formate schiere di coach che fanno la fila per tirar fuori questo talento da chiunque si cimenti in qualcosa. Tutti possono farcela! La realtà, ahimè, dimostra che ad essere talentuosa, in ogni campo, è una sparuta minoranza. Spesso è come mettere una pietra sopra uno spremiagrumi. Non esce niente.
Gli altri, quelli della squadra di Aristotele, sostengono che hai delle potenzialità, ma che vanno portate in atto attraverso il lavoro, la disciplina, i metodi corretti di allenamento, gli insegnamenti. Sì, ma è evidente che non basta allenarsi come Pietro Mennea per avere i suoi tempi sui duecento metri.
In tanti anni ho trovato atleti che recriminavano: in palestra lavoro molto più di Tizio e tu fai giocare lui.
Avevano ed hanno ragione.
Lavorano più di Tizio, ma Tizio è più performante.
Perché? Lo stesso Mennea, sminuendo il suo grande allenatore Carlo Vittori, ha detto più o meno: lui allena tutti allo stesso modo, ma gli altri si rompono e io ho fatto il record del mondo.
Per me il vento soffia sempre dalla parte degli innatisti, ma nel forcing attuato dalla squadra avversaria, con l’ausilio della tecnica di cui disponiamo oggi e delle tecniche di allenamento, la partita finisce in pareggio.
Se hai un approccio cognitivo ed utilizzi un metodo di allenamento conseguente (giusta tecnica, ripetizioni bloccate, c’è una soluzione uguale per tutti, …) ottieni buoni risultati. Non a caso strada ed oratori sono stati soppiantati da scuole calcio, accademie del volley, università del nuoto... i ragazzi, tutti vestiti uguali, tutti allenati in maniera uniforme diventano bravini.
La sfida va ai supplementari. In una partita molto bloccata e onestamente noiosa succede qualcosa.
Un giocatore della nostra squadra riceve il pallone, con il primo controllo si libera dell’avversario che gli è alle spalle e, senza alzare gli occhi, con un tiro a giro, ma al tempo stesso potente, la mette nell’angolino opposto a quello presidiato dal portiere e fa gol.
Che ne sapeva che l’avversario lo avrebbe pressato dal lato opposto rispetto a quello verso il quale si è girato? Come poteva vedere la porta se guardava il pallone? Che notizia aveva sul posizionamento del portiere, sui suoi movimenti?
Anni di allenamenti?
No, queste cose non si insegnano, le hai dentro. Poi quel tocco così vellutato e preciso non è da tutti.
Partita chiusa.
Bene, con mio sommo dispiacere, ammetto che non è così. Vivendo in allenamento migliaia di volte la stessa situazione, puoi sapere dove è il portiere e cosa stia facendo anche se non lo vedi. Il nostro computer immagazzina una quantità infinita di dati, li raccoglie ed elabora una statistica. Poi ci comportiamo di conseguenza.
Abbiamo allenato l’esperienza!
Sia chiaro, quando parlo di allenamento a maggior ragione parlo di gioco in strada o sulla spiaggia, ma questo è un altro capitolo.
L’esperienza non è talento.
Si va ai rigori.
Qui entra in campo un nuovo paradigma ed è quello che decide la finale.
Ok, l’esperienza può essere allenata e il suo output somiglia al talento. Ma non basta.
Proviamo a ipotizzare: i grandi campioni non hanno bisogno di razionalizzare, imparano a muoversi percependo dall’ambiente circostante ogni invito all’azione.
C’è un video in cui Ronaldo segna un gol al buio.
L’interpretazione più convincente di questo esperimento è che CR7 abbia maturato la capacità (apparentemente istintiva) di cogliere dal minimo indizio la traiettoria della palla. Chiamiamola esperienza se vogliamo, perché questa capacità va allenata, ma la chiave è nel rapporto percettivo con l’ambiente.
Ora, nell’esperimento CR7 al buio si può argomentare tutto questo e il contrario di questo con dovizia di particolari e con efficacia (la capacità predittiva sulla traiettoria del cross data dall’esperienza e da mille situazioni vissute è un buon argomento, ma non fa che rafforzare l’argomento ecologico ).
Il fatto è che la pratica sportiva ci cambia un po’ la storia della filosofia. Il ritorno dalla pratica alla filosofia è segnato da un punto: l’acquisizione delle nostre abilità si emancipa dalla diatriba tra innatismo e razionalismo. Sostenere che si nasce talenti e lo si diventi ha poco a che vedere con l’acquisizione delle abilità sportive, niente a che vedere con la questione tra innatismo e razionalismo.
C’è quindi una terza via evidenziata dalla pratica sportiva:
l’apprendimento (motorio nel caso sportivo) è dato dal rapporto produttivo con l’ambiente, che ci invita ad esercitare movimenti che sembrano innati o il risultato di addestramenti meticolosi, ma che in realtà sono il frutto della capacità di assecondare delle percezioni che hanno già nel loro contenuto un invito all’azione (Affordances).
Più sono capace di mettermi in sintonia e di assecondare le Affordances e più risolvo problemi.
C’è un altro video del quale dovremmo occuparci. The last shot. Michael Jordan, 14 giugno 1998, ultimi 18 secondi della serie di finale, Bulls contro Jazz. I Bulls sono sotto di un canestro, palla a Jordan che l’ha scippata a Malone percependone il movimento, lo aspetta un avversario, Russel, lui, Jordan, va a sinistra, tutta la sua squadra a destra. E’ uno contro uno, tutti sanno che in questa scena possono essere soltanto spettatori. Tutti tranne Russel, l’uomo a cui tocca marcare Jordan. MJ affonda verso il centro, il suo avversario lo chiude, si sbilancia, MJ gli poggia la mano sulla schiena, una leggerissima leva per tenersi in equilibrio e tornare sui suoi passi, prende le distanze dall’avversario, si ferma e tira, forse lungo, forse corto, se ne accorge, corregge con il polso e mette a segno uno dei canestri più iconoci della storia NBA, quindi del basket.
Il bello è il racconto dello stesso Jordan, chiamato a rivivere quella scena migliaia di volte: non ha pianificato nulla!
Una serie di reazioni alla situazione di gioco ed alla percezione di quanto stesse accadendo.
Lui mi ha seguito per chiudermi la strada verso il centro del campo ed allora mi sono fermato, lui non si è fermato nello stesso istante ed allora ho fatto un passo indietro. Lui è tornato e mi sono distanziato per prendermi il tiro. Fino al gesto finale: ho sentito che la traiettoria usciva corta e ho corretto con il polso appena in tempo.
Ok, credo che Jordan ci abbia pensato dopo. Visto che ci ha messo minuti a raccontarlo e che l’azione è durata pochi secondi, tredici da quando ruba palla a Malone (ho capito cosa stesse per fare) e quando quella stessa palla si infila nella retina.
Questo è quello che vediamo nello sport e lo vediamo continuamente, in situazione più ordinarie e meno epiche. Ci sono degli “imbuti”, vincoli, che ti costringono a fare dei movimenti o a pensare determinate scappatoie senza che tu debba riflettere o debba far riferimento razionale ad una tecnica sempre uguale. Ci sono delle percezioni che ti invitano ad agire nella direzione migliore. L’unica possibile.
Nella pratica dell’allenamento mi pare chiaro. Posso insegnare alle mie pallavoliste come utilizzare il polso nel colpire un attacco. Ci sono metodi collaudati che più o meno funzionano, ho davanti venti ragazze ed insegno a tutte la stessa cosa. La faccio ripetere per 10.000 ore ed il gioco è fatto. Quest’ipotesi, riproposta dallo psicologo svedese Anders Ericsson, è poi diventata famosa anche presso il grande pubblico grazie al libro Fuoriclasse. Storia naturale del successo in cui il giornalista Malcom Gladwell elenca una serie di personaggi che sarebbero arrivati al successo con la pratica costante e ostinata che lui quantifica in circa “diecimila ore”. Phelps disse più o meno la stessa cosa rispetto al suo stile libero. Un articolo divulgativo della rivista Focus racconta le obiezioni a questa teoria, tornando a spostare la questione sul talento innato. Buona l’analisi, insufficiente la soluzione proposta da Focus.
Indubbiamente se sei alto due metri e pesi centocinquanta chili non sarai mai un buon fantino. Così come quasi tutti i fantini di successo non hanno le caratteristiche dei giocatori di basket.
L’acquisizione delle abilità, però, è questione più complessa.
Tiriamo questo rigore decisivo tornando alle nostre pallavoliste che imparano ad utilizzare il polso nel colpo d’attacco.
Ci sono delle percezioni che obbligano ad adottare soluzioni e possiamo indirizzare queste percezioni impenendo dei vincoli. I vincoli più evidenti sono quelli della rete e delle linee del campo. La palla deve varcare la rete e cadere dentro le linee del campo. L’atleta che colpisce la palla adatta spontaneamente e in maniera diversa per ciascuna delle venti pallavoliste e diversa per ciascun colpo di ognuna il proprio movimento del polso, nel tentativo di superare la rete e mandare la palla in campo. Non solo il polso, l’atleta auto organizzerà nella maniera più efficace la catena cinetica, dal salto al colpo. Non funziona tutto al primo tentativo. E allora, invece di dare la soluzione, è opportuno chiedere. Cosa pensi che non abbia funzionato?
Sorprendentemente la risposta che ricevo è quasi sempre quella che avrebbe dato il manuale.
Nella teoria siamo brave!
È questo quello che spesso mi sento dire dalle mie ragazze.
Ricordiamo The last shot: la palla mi stava uscendo male e l’ho corretta nell’ultimo istante.
Ok, nel caso della pallavolo il coach può “suggerire” il pallonetto mettendo un muro (umano o artificiale) ad opporsi alla traiettoria. Non c’è bisogno che dica molto. L’atleta percepisce l’ostacolo ed è invitata ad un’azione per oltrepassare il muro: il vincolo sarà far cadere la palla oltre il muro. Così per la diagonale e altre tecniche.
Bene, a questo punto dalla filosofia siamo scesi nella pratica e nella pratica siamo tornati alla filosofia, con un approccio interdisciplinare, che si avvale, nel caso specifico, delle scienze cognitive.
C’è ora da fare sintesi e tornare alla vita sportiva, stabilendo dei punti che possono essere di aiuto all’allenamento sportivo ed alla teoria dell’apprendimento delle skills sportive.
Intanto è bene spostarci dalla domanda sul talento ad una nuova domanda: come ha acquisito le sue abilità qualcuno che riconosciamo essere un ottimo sportivo?
La risposta è: allenando l’esperienza.
Come si allena e di conseguenza si acquisisce l’esperienza?
Rob Gray, tra gli altri, elenca in modo efficace sei punti. Li riporto in inglese per mantenere la loro efficicacia. Se siamo proprio digiuni basta un copia incolla su qualsiasi traduttore.
1) Athlete-Environment Symmetry. Skill is all about the relationship the athlete creates and maintains with their environment. It is not all, asymmetrically, about what’s in their head. This is where the term “ecological” comes from – we are always including the performer’s ecology (their physical surroundings, the context) in looking at skill.
2) Direct Perception of Affordances. We pick up opportunities for action (affordances) directly from our environment without the need to process, interpret, or add to the information (e.g., from previous experiences). As JJ Gibson5 so wonderfully put it: our environment structures the sensory information we receive in meaningful ways.
3) Information-Movement Coupling. We control our actions prospectively by establishing and maintaining a relationship between the information we pick up from the environment and some aspect(s) of our movement. We don’t predict, plan, or program.
4) Self-Organization with respect to Constraints. The movements and positions of our body that we use to execute an action occur through a process of self-organization (the body finds its own solution if you will) NOT via a central executive in our head that tells our body what to do. Critically, this self-organization is shaped by the task (e.g., size of playing area), environmental (e.g., presence of wind), and individual (e.g., level of fatigue) constraints.
5) “Repetition without Repetition”. Successfully repeating a performance outcome (e.g., always getting a basketball in the hoop) is NOT achieved by repeating the same movement over and over. We need variability in our movement from execution to execution to allow us to adapt to the variability in the internal and external environment.
6) Direct Learning Through Experience. With practice and experience, we become more skillful by changing our relationship with our environment and adapting our information-“
Da allenatore sportivo amo particolarmente il quinto punto, la distinzione tra l’allenamento a blocchi tradizionale e quello aperto, ecologico.
Ripetizione senza ripetizione!
Gray mutua questa convinzione da un esperimento condotto dal fisiologo russo Bernstein su esperti fabbri. E’ vero che con il loro martello colpivano sempre nella stessa maniera il ferro, ma i tracciati del movimento del braccio dimostravano che, sebbene l’output del colpo fosse identico, il movimento che lo precedeva era ogni volta diverso.
Nessuna palla che ho colpito era uguale all’altra, disse una volta Nadal.
Quindi, si nasce più o meno predisposti ad essere talenti, ma è la nostra efficace relazione con l’ambiente e la nostra capacità di auto organizzazione che fa la differenza.
Ebbene, cosa restituisce questo punto alla filosofia?
Tante cose, mi permetto di focalizzarne una: l’attenzione nella nostra relazione con il mondo non è fondata (soltanto) sulla conoscenza e la conoscenza del come fare, ma sull’invito a fare, sull’ acquisire abilità trasformative anche in modo non riflesso.
Chiamiamo tutto questo esperienza.
Tutto quello che noi esploriamo, anche attraverso una percezione inconsapevole che contiene un efficace invito all’azione, ci porta ad agire nel senso di questo invito, a trasformare e trasformarci, ad essere un qualcosa di diverso, ma sempre in connessione all’ambiente nel quale viviamo e in relazione al quale ci auto organizziamo, mantenendo un rapporto costante con il mondo che ci circonda. Le nostre azioni sono figlie delle nostre percezioni e di conseguenza dell’ambiente che ci circonda.
Se ci pensa un attimo, anche Michael Jordan sarà d’accordo.