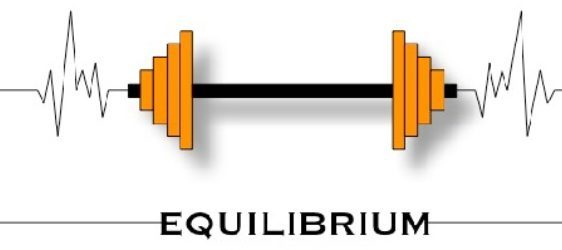Non prendiamoci in giro.
Tutti abbiamo urlato almeno una volta in palestra. Un ruggito secco, improvviso, che nasce quando qualcosa va storto nel momento sbagliato: un errore “imperdonabile”, agli occhi dell’allenatore.
Settimane passate a lavorare su palla libera.
Quinto set, tredici pari.
Il libero alza la palla sulle mani del centrale avversario che schianta la palla nei nostri tre metri.
L’urlo di Munch, a confronto, impallidisce.
Negli anni ho imparato a ridurre questi scoppi, che nel mezzo della mia carriera erano accompagnati da lanci di cartelline, pugni sul muro, calci a tutto quello che era a portata. Non perché io sia diventato più buono, o come dice qualche atleta che ho allenato in passato, mi sia rimbambito, ma perché ho cambiato prospettiva.
Oggi urlo meno non per autocontrollo morale, ma per una idea diversa che ho maturato a proposito di cosa sia l’errore.
Non lo considero più una deviazione colpevole dal gesto corretto.
L’errore è prima di tutto un’informazione.
L’errore come messaggio, non come colpa
Se guardiamo l’errore dentro un sistema ecologico, cambia tutto.
Un errore non dice che l’atleta “non sa fare”, ma come stia leggendo l’ambiente: quali affordance stia percependo, quali vincoli stiano orientando la sua azione.
Quando una ragazza sbaglia, non sta semplicemente “eseguendo male”. Sta rispondendo a ciò che vede, sente, anticipa.
L’errore è il risultato di una relazione confusa tra percezione e azione.
Eppure molti atleti, dopo un errore, iniziano subito il rosario degli alibi:
la luce, il rumore, il faretto, il pallone, il cambio climatico, l’invasione delle cavallette.
Velasco ha ragione quando liquida tutto questo come alibi.
Ma fermarsi lì non basta.
Perché se l’atleta sbaglia, un motivo c’è, e non è (solo) psicologico o caratteriale. È percettivo. È sistemico. È situato.
SE Quando togli l’alibi, resta il vuoto
Dire a un’atleta “niente alibi” ha senso solo se poi le offri un contesto che le permetta di capire cosa sta succedendo.
Altrimenti succede questo: al primo errore togliamo l’alibi, al secondo togliamo la fiducia, al terzo sollecitiamo il sentimento di colpa.
La colpa è il contrario dell’apprendimento.
Non è raro sentire l’allenatore sbottare:
“Ma non vedi che è una float? Devi anticipare!”
Ecco il punto: la ragazza non lo vede.
Non perché sia distratta o pigra, ma perché non è allenata a cogliere quell’affordance. Il problema non è la volontà, è la percezione.
L’errore come esplorazione
Quando qualcosa “va storto”, il sistema sta comunicando qualcosa.
Il corpo esplora, tenta, aggiusta. A volte fallisce. È così che si impara.
Il volley non perdona e le occasioni di errore sono frequenti:
una ricezione lunga, un tempo d’attacco sbagliato, un muro fuori tempo.
Non sono solo errori biomeccanici. Spesso sono tentativi di adattamento non riusciti. Segnali di come l’atleta sta interpretando vincoli e possibilità.
Ecco perché di fronte all’errore la mia reazione, oggi, non è dare un’istruzione, ma chiedere: perché? Credo che questa sia la cosa che dico più frequentemente in palestra: perché?
Sì, ogni tanto urlo ancora
Non faccio il santarello. La scorciatoia dell’urlo è sempre lì, pronta.
“Ma non lo vedi?!”
L’urlo libera me, non l’atleta.
E quando lo riconosco, torno al punto di partenza: non correggere il gesto, ma il contesto.
Perché l’apprendimento non nasce dalla ripetizione sterile, ma dalla possibilità di leggere meglio ciò che accade intorno.
Verso il prossimo passo
Se l’errore è informazione, allora la vera domanda non è come eliminarlo, ma come progettare ambienti che lo rendano utile. Certo gli errori sono fastidiosi e vanno eliminati. In realtà vanno trasformati. Come?
Nel prossimo post entreremo nel cuore operativo dell’approccio ecologico:
vincoli e rumore come strumenti cardine per combattere il lato oscuro del volley.